Caro direttore, non ho visto, nel singolo piano di sequenza, (la ripresa continua e ininterrotta di un’intera parte) le quattro puntate della miniserie Adolescence nella produzione Netflix. Con questo non voglio dire che se le avessi viste con rigoroso impegno anch’io, sarei stato capace di spiegarle bene come ha saputo fare Katia Regina in “Adoloscence: un piano sequenza necessario”. La quale per cominciare ha affermato che la visione della miniserie produce gli stessi effetti della narrazione immersiva in letteratura, ossia quel genere di tecnica che ti incolla alle pagine e non ti consente di posare il libro se non alla fine”.
Fatta questa breve premessa e leggendo con il solito interesse il seguito dell’articolo, mi sono imbattuto in istruttivi e stimolanti riferimenti, inclusi quelli di carattere tecnico che, insieme alla storia, ai suoi personaggi e alla tesi che si voleva dimostrare, mi hanno suggerito altri importanti spunti di riflessione. Credo che abbia colto in pieno l’obiettivo che gli stessi autori della miniserie volevano perseguire: lasciare il segno in questa fase di frenetica turbolenza che è caratterizzata dall’assenza del lieto fine, per giunta priva di catarsi e di facile e gratuita redenzione. Ma con la dannata voglia di recuperare una nuova normalità. Per ottenere la quale occorre mettere in guardia i genitori sui modelli educativi tossici che i loro figli possono incontrare online. Che forse costituisce l’origine e la causa della prima difficoltà che è quella di distinguere la lingua dal linguaggio in cui risiede un passaggio ineludibile rispetto al quale è necessario porsi la domanda sul perché alcuni strumenti, utilizzati dagli adolescenti, diventano il peggiore veicolo per l’assunzione e il compimento di inspiegabili nefasti comportamenti. In proposito ci sono alcuni suggerimenti utili indicati nell’articolo che vale la pena valutare.
Più in generale possiamo dire che quello dell’adolescenza, paradossalmente, oltre che un fenomeno è anche un noumeno, nel significato platonico e kantiano. Anche perché, vuoi o non vuoi, prima o poi, con l’adolescenza, direttamente o indirettamente, ognuno è costretto ad avere a che fare (e a che dire) durante l’intero arco della sua esistenza. In ogni epoca, ciascuno di noi può essere coinvolto anagraficamente e biologicamente, indipendentemente dal fatto se essa sia connotata da una adolescenza senza tempo o sia determinata da una adolescenza, che per vari motivi, endogeni ed esogeni, viene sospesa e interrotta. Sul piano sociale, economico, culturale, familiare, della salute fisica e psichica, inclusi i fattori esterni e immutabili, come l’estetica e la genetica, di cui fanno parte il cosiddetto fenomeno della sottocultura incel (celibi involontari, odiatori delle donne) e la cosiddetta ideologia estremista di Redpill, occorre fare uno sforzo per contenerne e scongiurarne la portata.
Non tutti questi passaggi vecchi e nuovi (penso al Covid19, che ha coinvolto il Pianeta e penso alle guerre in atto che producono tensioni, paure e incertezze) sono stati vissuti allo stesso modo. Non è qui il caso di parafrasare l’incipit di Guerra e Pace di Lev Tolstoi: “Tutte le famiglie felici si somigliano; ogni famiglia infelice è invece infelice a modo suo”. Né di ripetere la solfa che l’adolescenza è un’età critica, ma che ci sentiamo confortati all’idea che sia solo una fase da sopportare e supportare e che quindi è destinata a finire e a consegnarci individui maturi e pronti alla vita adulta. Sappiamo però che l’adolescenza non è proprio e sempre così. Abbiamo appreso dal racconto che la famosa crisi adolescenziale non è una semplice crisi. Bullismo, odio, misoginia e altri fatti ed episodi raccapriccianti raccontano le zone d’ombra dell’adolescenza moderna. Ma non sappiamo se la miniserie Netflix sarà destinata a scuotere la società. Non oso dilungarmi sulla complessità del periodo adolescenziale, su cui continuano ad esprimersi, non solo gli esperti della materia, come è giusto che sia, ma anche l’intera opinione pubblica, che è tenuta a dire la propria e a prendere le dovute precauzioni per la semplice ragione che nessuno può chiamarsi fuori, sia per la diversità dei ruoli, che per l’assunzione delle responsabilità e delle colpe e che tutte e tutti, chi più e chi meno, hanno contributo a creare la crisi in cui ci dibattiamo.
Questo vale per i soggetti: i genitori, gli insegnanti, gli studenti e vale anche per le istituzioni: la scuola, lo Stato. Mi fermo qui per evitare di cadere nell’ovvietà e nell’irrilevanza, del detto e ridetto, del trito e ritrito. Mi preme invece sottolineare la necessità di continuare a riflettere sull’imperscrutabile mistero dell’adolescenza e sulla responsabilità dei genitori e della società, oggi. Mi pare opportuno segnalare, per averlo potuto constatare, che negli ultimi anni sempre più l’identità personale degli adolescenti si intreccia con la valutazione dei coetanei, che esercitano, nel bene e nel male, un’influenza determinante sulla percezione di sé. Questo aspetto è stato messo in luce anche da ricerche neurobiologiche recenti che hanno confermato come la percezione di sé sia influenzata fortemente dal modo in cui si è percepiti dai coetanei. Ma non ho suggerimenti da dare. Anche se sono preoccupato di come stanno andando le cose nel mondo dell’adolescenza e nella società. E se per invertire la rotta sia necessario rafforzare il sistema democratico, come auspico, o il prevalere di forme esplicite e ibride di “democrature”, che temo.
Filippo Piccione

 Sezioni
Sezioni













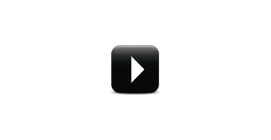


 Lega Navale di Trapani tra
Lega Navale di Trapani tra


