Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle, ha organizzato una manifestazione a Roma per protestare contro il riarmo dell’Unione Europea, a favore della pace. E poiché non si è "anime belle", si sa bene che ci sono interessi economici enormi attorno ai conflitti, e chi ci specula sopra.
Ursula von der Leyen ha recentemente proposto un piano per il riarmo dell’UE da 800 miliardi di euro. È utile ricordare che l’Italia dovrebbe contribuire con una quota tra i 26 e i 27 miliardi di euro in un arco di 4-5 anni. Parte di questi fondi sarà destinata – come sta dimostrando il conflitto nella terra di Gogol – allo sviluppo di tecnologie dual use, ovvero utilizzabili sia in ambito militare che civile. Infatti, molti scontri oggi avvengono anche sul fronte tecnologico.
Uno degli argomenti toccati durante la manifestazione è stato quello secondo cui una pace fosse possibile già nell’aprile del 2022, con il famigerato "Istanbul Communiqué". Si accusa l’ex premier britannico Boris Johnson e la diplomazia americana di aver fatto pressioni sul governo ucraino affinché l'accordo venisse abbandonato, spingendolo a proseguire la guerra.
Facciamo un passo indietro. Nel giugno 2023, Vladimir Putin rese nota l’intesa proposta in Turchia, denominata "Trattato sulla neutralità permanente e sulle garanzie di sicurezza per l’Ucraina". Il testo, a suo dire molto dettagliato, venne però "gettato nella pattumiera della storia" dalle autorità di Kiev e dai loro alleati.
I punti salienti del trattato erano: l’Ucraina si impegnava a restare neutrale e a non entrare nella NATO.
La Russia rinunciava alla richiesta di smilitarizzazione e “denazificazione”, accettando invece l’adozione da parte di Kiev di una legge specifica. Inoltre, dava il suo assenso all’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea. L’Ucraina chiedeva garanzie sulla propria indipendenza. Si proponeva una riduzione dell’esercito ucraino da 250.000 a 85.000 uomini. Kiev chiedeva di mantenere 800 carri armati, mentre Mosca ne accettava solo 342.
Nonostante gli orrori di Bucha, il dialogo proseguì. Il nodo cruciale restavano le garanzie: si cercavano meccanismi molto più solidi e concreti rispetto a quelli del Memorandum di Budapest del 1994, con cui l’Ucraina aveva rinunciato alle proprie testate nucleari in cambio della promessa – poi disattesa – di non essere aggredita (come avvenne nel 2014 con l’annessione della Crimea).
Nella bozza del 12 aprile 2022 era specificato che gli Stati garanti avrebbero deciso autonomamente se intervenire in aiuto dell’Ucraina in caso di un nuovo attacco russo. Tuttavia, nella versione del 15 aprile – l’ultima nota – i russi cercarono di modificare questo punto cruciale, chiedendo che l’aiuto potesse avvenire solo previa decisione unanime di tutti gli Stati garanti.
E qui il paradosso: tra gli "Stati garanti" figurava anche il Consiglio di Sicurezza dell’ONU, di cui fa parte la stessa Russia, con diritto di veto. Alla luce di tutto ciò, chiunque dotato di buon senso non avrebbe potuto firmare quell’accordo. È facile volere la pace... con i morti degli altri.
Per concludere, con le parole di Winston Churchill: "In tempo di guerra, la verità è così preziosa che bisogna sempre proteggerla con una cortina di bugie."
Vittorio Alfieri

 Sezioni
Sezioni













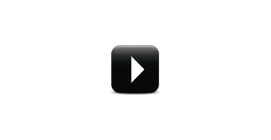


 Lega Navale di Trapani tra
Lega Navale di Trapani tra


